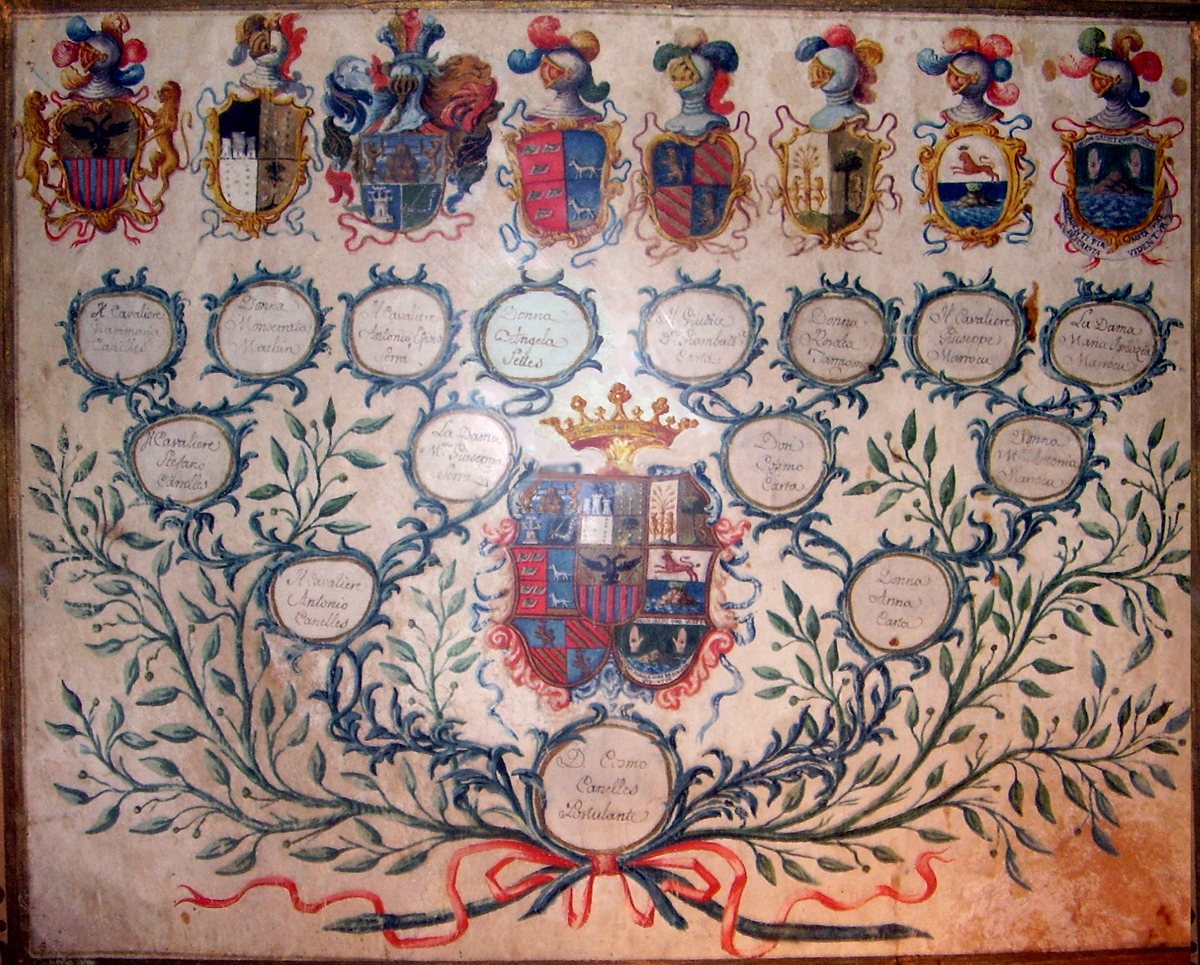Lo tsunami antropologico ci sta investendo in tutta la sua portata, con un’opinione pubblica che oscilla fra sconcerto, rassegnazione e indifferenza, mentre la politica arranca, e alle sue indecisioni sopperiscono frequentemente magistrati sempre più “creativi”, che di fatto stanno assumendo il ruolo di legislatori sulle questioni cosiddette “eticamente sensibili” (e non solo, vedi il caso Stamina).
L’ennesima dimostrazione è la sentenza con cui il tribunale di Milano, in buona sostanza, ha legittimato un percorso di maternità surrogata di una coppia italiana, che per questo si è rivolta a una clinica in Ucraina. Il bambino nato ha una madre genetica – una donna ucraina che ha “donato” i propri ovociti –, una madre surrogata – una donna ucraina che ha portato avanti la gravidanza a pagamento –, e una legale – la donna italiana che ha commissionato il tutto, insieme a suo marito, che invece è allo stesso tempo padre legale e naturale.
Un patchwork assolutamente legittimo in Ucraina, dove il bambino è nato: secondo i nostri giudici questo è sufficiente perché la donna italiana sia riconosciuta come la “mamma” del piccolo anche nel nostro Paese.
Non è la prima sentenza che in Italia si muove in questa direzione: già in precedenza, in casi analoghi, il – doveroso – principio della tutela del minore aveva portato i giudici a risolvere i pasticci causati dalla pratica dell’utero in affitto lasciando il bambino con coloro che lo stavano crescendo, cioè con chi aveva commissionato la gravidanza a pagamento, a prescindere dalla legalità o meno dei percorsi seguiti.
Ma la tutela dei soggetti più fragili non può trasformarsi in un “tana libera tutti”: se è giusto e importante prendersi cura degli indifesi – la gestante a pagamento e il neonato, in questo caso – è essenziale sanzionare chi mercanteggia con gli esseri umani, a cominciare da chi lucra con le maternità a pagamento, trattando le donne più povere e vulnerabili come produttrici di ovociti e contenitori biologici, e inducendole a cedere i neonati dietro compenso.
Si delinea una tendenza per cui a livello nazionale e internazionale ci si limita ad affrontare l’inevitabile groviglio legislativo che si crea quando madri a pagamento, genitori genetici, committenti e cliniche specializzate appartengono a Paesi con legislazioni diverse e spesso in contraddizione fra loro. Se a tutto questo non si accompagna una volontà ferma e internazionalmente condivisa di punire chi vuole, consente e promuove il mercato delle gravidanze conto terzi, il risultato finale sarà una piena legittimazione dell’utero in affitto, magari considerato come una delle possibili varianti tecniche della fecondazione assistita...
Ma chiamare «tecnica riproduttiva» l’utero in affitto, accompagnato pure dalla compravendita degli ovociti, è solo un’ipocrisia pazzesca, detta da chi mente sapendo di mentire. E non basta: nel testo della sentenza si parla esplicitamente di «diritto alla genitorialità» (il che implica che esista qualcuno con un corrispettivo «dovere» a far sì che altri diventino genitori, e sarebbe interessante capire a chi spetti tale obbligo). Si afferma poi che il concetto dell’essere genitori oramai è «incentrato sull’assunzione di responsabilità» nei confronti del nascituro: quel che vale sarebbe l’intenzione di diventare genitore di chi ancora deve nascere, e non il fatto tangibile di generare un figlio.
Ma se i legami genetico e biologico non contano, allora per quale motivo chi si vuole assumere la responsabilità di crescere un bambino non si rivolge all’adozione, se concepimento e gravidanza non possono avvenire all’interno della coppia? Che senso hanno utero in affitto e compravendita di ovociti – cioè due madri “naturali” – se non quello di avere un figlio che “appartenga” geneticamente almeno a uno dei due della coppia, cioè almeno al padre? Ed è forse una inaccettabile provocazione chiamare tutto questo, anziché un diritto alla «genitorialità», piuttosto un diritto alla «discendenza», cioè quella che una volta veniva chiamata «la stirpe»?
Assuntina Morresi
Fonte: Avvenire